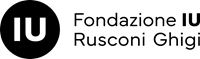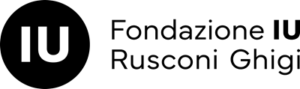A 13 anni si è chiuso alle spalle la porta di casa per l’ultima volta e ha cominciato a camminare. Dietro di lui, l’eco dei passi di chi, per dieci anni, ha continuato ad andare in avanti completamente solo, attraversando Iran, Turchia, Grecia, Serbia, Bosnia, Albania, Croazia.
Ahmed ha 23 anni, ma non lo ricorda.
Seduto al centro della cucina, infila una mano in tasca e tira fuori il portafogli. Estrae la carta d’identità, la tiene tra le dita. “Sono nato nel 2003 – dice-. Ma non ricordo molto. Non voglio e non posso ricordare”.
Pantalone mimetico e cappellino verde all’indietro, stringe una giacca di pelle tra le braccia, che non riescono a stare ferme. “Lungo il tragitto ho conosciuto tre ragazzi e siamo diventati molto amici. Sono morti tutti”.
Si ferma un attimo. Poi riprende. “Quando sono arrivato qui ero malato e c’era la neve. Ma non posso ricordare, scusami”.
Le frasi arrivano una dopo l’altra, tutte uguali nel ritmo e nel tono. Non importa cosa stia raccontando. É una voce che non sale e che non scende, come se nulla riuscisse più a fare la differenza, come se il dolore non avesse più gradazioni possibili. Solo le mani continuano a muoversi.
Arriva dall’Afghanistan, in inverno fa il muratore, d’estate il giardiniere, ma prima ha fatto di tutto: Il cuoco, il cameriere, il magazziniere. “Mando i soldi a casa per permettere ai miei otto fratelli di studiare, io non ho potuto farlo”.
Lo incontro una sera in uno degli appartamenti del progetto CASA, un progetto sociale di accoglienza abitativa e integrazione per migranti nato dalla collaborazione tra la Fondazione IU Rusconi Ghigi – che ha dato in locazione due appartamenti in via Petroni – Il Centro Astalli e l’Associazione Dialoghi, realtà che da anni operano a Bologna per favorire l’accoglienza dei migranti attraverso una rete di volontari, soci e sostenitori.
Il patrimonio immobiliare della Fondazione IU, centro di ricerca e innovazione per immaginare e realizzare il presente e il futuro della città di Bologna, non è una risposta all’emergenza, ma uno strumento di sostenibilità e innovazione sociale: uno spazio di sperimentazione di nuove forme dell’abitare. Il progetto CASA non intercetta i grandi numeri dell’accoglienza. Riguarda poche persone. Ma mostra cosa succede quando l’accoglienza finisce nel momento più fragile: quello in cui una persona deve ricostruire una vita da sola.
La luce è bassa, sul tavolo un panettone, alla parete è appeso un festone di Natale color argento. In TV, in sottofondo, la semifinale di Coppa D’Africa: Senegal contro Egitto. Seduti in cerchio, in cucina, ci sono anche N’golo, 21 anni, della Costa d’Avorio e Blaise (in foto), 27 anni, del Camerun. Hanno la voce delicata, i modi gentili. Sono arrivati entrambi con la barca in un Paese di cui non sapevano nulla. Prima Lampedusa, poi Bologna, al Centro Mattei, centro di prima accoglienza per migranti senza fissa dimora. Lì sono diventati amici.
“Eravamo più di cinquecento persone. Dormivamo in camerate da otto – racconta Blaise -. Non si riusciva né a studiare né a dormire. Siamo stati fortunati».
Fortunati è la parola che ripetono più spesso.
Dopo il Centro Mattei, entrambi hanno fatto una positiva esperienza in un progetto di seconda accoglienza: Blaise a Casa Maia, N’golo a Casa Makeba. Ma il percorso dell’accoglienza, pur permettendo a una parte dei migranti di ottenere un permesso di soggiorno, spesso si arresta prima che l’autonomia diventi reale. L’uscita dai CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) e dai progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione, ex SPRAR) coincide con la fine di un percorso, non quando una persona è davvero pronta a stare da sola. In quel passaggio la rete di protezione si interrompe. Da quel momento in poi, devono cercare un lavoro, un alloggio, e provare a costruire una vita fuori dal sistema.
Nell’area metropolitana di Bologna, al 30 novembre 2025, il sistema pubblico di accoglienza conta 3.830 posti in 429 strutture. Quasi il 60 per cento rientra nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), una quota più alta rispetto alla media nazionale, dove il sistema continua a fare maggiore affidamento sui Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS). In questo senso, Bologna si colloca in una posizione relativamente più avanzata nel percorso verso un’accoglienza strutturata e orientata all’inclusione.
Questo, però, non basta. La “seconda accoglienza” ha confini sfumati: il SAI è pensato per accompagnare verso l’autonomia, ma i posti sono insufficienti e, nella maggior parte dei casi, il percorso si interrompe prima che una persona abbia davvero accesso a una casa.
Dei passaggi successivi non esistono dati pubblici. Non c’è un censimento dei progetti di “terza accoglienza” o di accompagnamento abitativo verso l’autonomia. Sono pochi, frammentati, spesso affidati a fondazioni e associazioni. E raggiungono solo una minima parte delle persone che ogni anno escono dai progetti di accoglienza temporanea.
Quando è il momento di cercare un alloggio, sono poche le persone disponibili ad affittare a persone migranti.
Se trovare un lavoro significa spesso affrontare tentativi a vuoto e porte chiuse, resta comunque un obiettivo ancora raggiungibile. Molto più complessa, invece, è la ricerca di una casa, anche quando ci sono un contratto di lavoro, un reddito stabile e documenti in regola. Alla scarsità di abitazioni in affitto si intreccia la diffidenza.
Il rischio, è quello di rimanere in strada. E scomparire.
Grazie al progetto CASA invece, Ahmed, N’golo, Blaise e gli altri ragazzi vivono in due appartamenti messi a disposizione dalla Fondazione IU. Un trilocale abitato da quattro ragazzi e un bilocale da due. Ma una casa, da sola, non basta. Serve qualcuno che resti. Sono inseriti infatti in un percorso verso l’autonomia lavorativa e abitativa. Hanno potuto fare un percorso formativo, per poi proporsi al mercato lavorativo. Hanno tutti un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato e un regolare contratto di affitto intestato a loro, a canone di mercato, sostenendo da soli sia il canone che le altre spese legate all’appartamento. E non sono lasciati soli nemmeno ad attraversare anche quello che fa più male. I volontari accompagnano i ragazzi a gestire tutti gli aspetti burocratici. Quando escono dall’accoglienza si trovano però anche spesso soli, e in quel momento tornano ad emergere anche le ferite del passato. Hanno molto bisogno di relazione. Per questo li aiutano a trovare un senso di casa e a evitare che restino nella solitudine.
Sui fuochi della cucina ci sono due grandi pentole piene. “In casa ci aiutiamo – spiega Blaise.- prepariamo insieme da mangiare, facciamo la spesa, puliamo casa, ci dividiamo le spese. Ma non parliamo mai di noi”. Poi sorride: “regole non ne abbiamo, siamo giovani”.
“Integrarsi è tra gli aspetti più difficili – continua Blaise.- Qui c’è un altro modo di vivere, è stato difficile imparare la lingua, cercare lavoro, una casa, provare a fare le cose che ti fanno stare bene in Italia”. I volontari li affiancano in questo percorso: fanno da mediatori culturali, li aiutano a gestire le spese, spiegano loro diritti e doveri. Li accompagnano nella costruzione di un progetto di vita.
Blaise lavora come carrozziere. Ogni mattina prende l’autobus e va ad Anzola. “Mi piace molto il mio lavoro, e nella vita – dice – quando ti piace qualcosa non senti molto la fatica”. Oggi i suoi colleghi sono anche amici. Escono la sera, vanno a giocare a calcio. Poi sorride: “ma quando fa freddo mi piace stare a casa”. Ahmed, invece, il sabato sera va fuori a cena con la sua maestra di italiano e il marito, ma gli altri giorni non esce. “Sono stato tanto rinchiuso in prigione in Iran, Turchia e Croazia che sono abituato a stare dentro. Ma non ricordo molto, non voglio ricordare. Sono stanco, non voglio stare con gli altri”. Dietro di lui, non c’è solo il rumore dei passi, ma anche il rumore di una cella che si chiude dietro le spalle e soprattutto quello di una mente che ha “visto troppo” e non può permettersi di ricordare.
Ahmed non frequenta molti ragazzi della sua età. “Sto lontano dai giovani, Dio sa perchè”, mi dice. É invece molto legato agli anziani. “Sono gentili, aiuto spesso la mia vicina, la signora Arda, che ha 90 anni, a portare la spesa”. Poi sorride: “É venuta anche con me alle cene del Centro Astalli”.
La casa, in queste storie, non è solo un luogo fisico. È il punto in cui smettere di sopravvivere e provare a fermarsi, a ricostruire una vita. Le storie che attraversano questi progetti partono tutte da una mancanza di riparo, prima ancora che da un’idea di futuro. E i sogni, qui, non hanno la forma che ci aspettiamo. Non sono grandi progetti, né promesse a lungo termine. A volte è solo il tentativo di andare avanti, anche senza sapere ancora esattamente dove.
“Da bambino non avevo un sogno – dice Ahmed-. Non me lo sono mai chiesto. Lavoro, vado avanti. Vivo e basta. Anche se questa vita, non è fatta per vivere”.
Reportage di Silvia Santachiara
Foto di Massimiliano Donati | In foto: Blaise